Schopenhauer e il pessimismo di mio nonno
Mio nonno spesso rispondeva in dialetto reggiano “Andòm mèl” (Andiamo male) e non aveva letto Schopenhauer. Aveva perfetta salute e anche un po’ di soldi, faceva l’orefice in casa, ma se qualcuno gli chiedeva “Nino, come va?”, lui rispondeva con un sorriso allusivo: “Andòm mèl”. Anche con più “e”, così sembrava davvero che andasse ancor peggio. Voleva compassione, aveva raggiunto l’ascesi schopenhaueriana? Neanche per idea. Era un modo di dire. Tipico della cultura contadina, che custodiva con pudore i suoi sentimenti e che non amava ostentare uno stato di benessere, che ognuno voleva tenersi assolutamente per sé. Schopenhauer, invece, il suo malessere l’ha rivelato a tutti. E quando si parla di Schopenhauer in molti pensano ad una sorta di iettatore che ha perfino fatto venire la gobba a Leopardi per farlo rifiutare da Silvia. Si chiamava Arthur ed era nato a Danzica, nel 1788, e suo padre era un ricco commerciante e sua madre una brava insegnante. Il papà si interessava anche di politica, era volterriano, e odiava la Prussia che nel 1793 aveva violato l’indipendenza della sua città, annettendola. Anche allora forse valeva il futuro detto: “Mourir pour Danzique”? Papà morì presto e con con mamma Arthur non ebbe mai un rapporto eccellente. Dopo essere stato ad Amburgo e a Parigi se ne andò in Inghilterra, poi a Gottinga, dove conobbe Hegel che gli parve “un gran ciarlatano” e a Berlino, ove studiò anche con Fichte, che non lo trascinò mai nel piacere della filosofia. Tanto che, poco dopo, si iscrisse a medicina, ma nel 1881 a Berlino finalmente scoprì l’amore per i filosofi, soprattutto per Kant, si laureò a Jena e nel 1819 pubblicò il suo libro più famoso, “Il mondo come volontà e come rappresentazione”. Era già diventato Schopenhauer. Solo che quel libro fu un mezzo fiasco, come la prima del Barbiere di Siviglia di Rossini di due anni prima. Volle, da insegnante all’università di Berlino, fissare le sue ore di lezione nelle stesse di Hegel per sottrargli gli uditori. Ma non ebbe lo stesso successo di Enrico Mentana al Tg sette. Forse anche per questo il suo pessimismo crebbe a dismisura. Diventerà famoso solo più tardi, nel 1851, col suo volume “Parerga e paralipomeni”, che gli porterà gloria anche per i suoi lavori precedenti. E che rimanda a quel famoso discorso di Francesco Crispi che nessuno riuscì mai a decifrare: “Se l’ipotiposi del sentimentalismo nazionale fosse capace di prostergare nel proprio subiettivismo la genesi delle concomitanze solo allora la democrazia rappresenterebbe l’autofasi della palingenesi sociale”. E qualcuno applaudì. Per capire Schopenhauer bisogna inquadrarlo nel romanticismo e nel bisogno di scoprire felicità e soprattutto infelicità dell’uomo, che non è più trattato come un essere più o meno astrattamente pensante (vedi Kant e Hegel), ma invece dotato di sentimenti, di dolore (frequentemente) e di piacere (raramente). E che anzi è mosso sempre dalla ricerca di un piacere insoddisfatto. Qui entra in gioco il pessimista Arthur, il cui padre, dicono, pare si sia suicidato, e che aveva conosciuto il romanticismo tedesco di Schiller e dello “Sturm und drang”, tempesta e assalto, così propenso ad esaltare le passioni, dopo che il povero Schopy aveva anche perso il confronto con Hegel e aveva fatto fiasco col suo capolavoro. L’uomo, per Schopenhauer, è alla ricerca spasmodica della felicità o piacere (che per lui è sempre sentimento), e che non trova perché mosso dalla volontà. E paradossalmente il suo piacere nasce quando c’è l’assenza di dolore, o dopo un dolore quando quest’ultimo è svanito. Che bella vita però, eh? Da Kant egli assume la differenza tra fenomeno e noumeno. Anche se Kant non aveva spiegato bene la identità del noumeno. E’ la cosa in sé, cioè tutto quel che non è pura apparenza (fenomeno). Per Schopenhauer la cosa in sé è la volontà. E’ un’attività sempre presente e mai razionale. E’ una specie di motore del mondo. Dove ci porta mai la volontà? Alla sofferenza, perché il mondo, in cui l’uomo si affratella con gli altri uomini, ne assume il dolore e lo condivide (con compassione), esprime un dolore cosmico. D’altronde l’individualità è un’illusione e l’universo sanguina sofferenza e frustrazione. Che vuoi che se ne faccia di un Dio che dovrebbe, se mai ci fosse, essere il più malvagio di tutti perché creatore e interprete delle perfetta infelicità? Nietzsche lo definirà “il primo ateo dichiarato e irremovibile che noi tedeschi abbiamo avuto”. Non c’era scampo per Schopy, nemmeno il suicidio era una soluzione, perché anche nel suicidio c’è una volontà di vita. Chi si suicida lo fa per un’affermazione di responsabilità. La soluzione è nelle filosofie orientali, nel buddismo (Schopy teneva sul suo tavolo, oltre al busto di Kant anche quello del Budda) e la soluzione finale è l’ascesi (anche l’arte è buona perché contemplazione pura e la carità e perfino la castità possono essere discreti antidoti, ma solo temporanei). La castità è utile perché all’atto del massimo piacere fisico si associa quello orrendo della riproduzione di tanti nuovi infelici. Allora non esistevano ancora i contraccettivi e le pillole, e dunque un piacere fisico puro era difficile da immaginare. Se no Scupy avrebbe forse anche cambiato opinione sulla castità e avrebbe propagandato la più sfrenata sessualità, anche questa però di natura passeggera. Esisteva sempre, se non la certezza, almeno il pericolo di generare nuovi mostri. Gobbi, poveri, infelici, sempre alla ricerca di un piacere inesistente, addolorati fino al midollo, straziati dalla sofferenza cosmica. Maledetti da un Dio che manco c’è, se no dovrebbe essere il più “sfigato” di tutti, per usare un aggettivo di un giovane neo vice ministro. Anzi, sosteneva Schopy: “Ma colui che ha inventato l’amplesso in cui si raggiunge l’orgasmo seminando le radici di un nuovo essere umano deve proprio essere alquanto sadico”. Che contraddizione è mai questa? Il piacere che genera l’infelicità? Perché non sia allora arrivato all’esaltazione dell’omosessualità resta un mistero. L’ascesi, dunque, il massimo distacco, la negazione della volontà, la noluntas, questo era il rimedio finale. Solo che lui, Schopy, mica praticava queste teorie. Anzi, lui era solito pranzare nei migliori ristoranti (altro che ascesi e digiuni che pure aveva raccomandato), avere amori e amorazzi a getto continuo senza preoccuparsi troppo di generare i figli della colpa (altro che castità), una volta (a proposito di carità) lanciò dalle scale la sua cucitrice solo perché stava parlando con una donna fuori dalla porta. E fu costretto a pagare alla poveretta un mensile piuttosto salato. Volente o nolente, carissimo Schopy. Kierkegaard commenterà a tale proposito: “Quando si è letta da capo a fondo l’Etica di Schopenhauer, si arriva a sapere (onesto fin qui egli naturalmente lo è) che per suo conto egli non è un simile asceta. Dunque lui stesso non è la contemplazione raggiunta per via dell’ascesi, ma una contemplazione che si rapporta contemplando quell’ascesi…….Ma anche a questo modo la cosa non va, perché è sempre uno sbaglio esporre un’etica che non esercita sul maestro tale potere così che egli stesso l’esprima nella sua vita”. Ma che importa. Chi è Schopy per Schopy? Non esiste e basta. E’ solo un’illusione. Chi deve giudicare l’ascesi del filosofo dell’ascesi? Quel che resta non è la cucitrice del filosofo, ma la cucitura della sua filosofia. Che influenzerà così tanto Nietzsche e anche Wagner e la storia della filosofia successiva. E che farà dire, poco prima di Marx: “Depressi di tutto il mondo unitevi”. La serotonina vi attende.











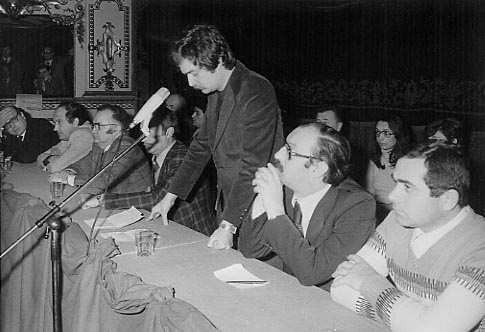

































































Leave your response!