La vera storia del luglio 1960
Dopo le dimissioni del governo Segni a febbraio il presidente Gronchi si arrovella, pensa a Leone e poi allo stesso Segni per una politica diversa e per un’alleanza che apra ai socialisti. Il nuovo colossal “Ben Hur” (a Reggio si stava anche in piedi al D’Alberto e l’attesa per un biglietto durava ore) tiene tutti col fiato sospeso. Anche la soluzione della crisi di governo appare lasciare aperti diversi sbocchi. Alla fine è Fernando Tambroni, un esponente democristiano sessantenne, legato alla sinistra, che a Firenze si era esposto per il dialogo coi socialisti, a dir di sì al presidente della Repubblica. Gli uomini cambiano per difendere il loro potere e Tambroni, che doveva aprire a sinistra, si trovò prigioniero dei voti della destra.
La fiducia di aprile passò con i voti del Msi e di quattro monarchici e questo provocò le dimissioni dei ministri della sinistra Dc. Il Msi diventava determinante per sostenere un monocolore democristiano. Gronchi tenta un’altra soluzione. È sembra fatta con Fanfani che pensa a un governo con Psdi e Pri e l’astensione del Psi. Ma la Dc lo blocca. Gronchi rimanda allora Tambroni alle Camere e il governo ottiene per la seconda volta la fiducia coi voti determinanti del Msi. Dal punto di vista istituzionale il comportamento di Gronchi non faceva una piega. Eppure per questo tutto il suo settennato verrà rivisitato in termini critici da parte della sinistra che pur l’aveva votato nel 1955. Il governo Tambroni aveva ottenuto la fiducia di una maggioranza parlamentare.
La stessa Dc, il 27 aprile, aveva approvato la dichiarazione del presidente del Consiglio. Oltretutto non era neppure la prima volta che il Msi votava a favore del governo (era già avvenuto con Segni, ma senza che i voti missini risultassero determinanti). Quel che fece tracimare l’indignazione del popolo della sinistra fu la convocazione del congresso del Msi, che si sentiva oggettivamente ringalluzzito dal nuovo ruolo parlamentare, proprio a Genova, città medaglia d’oro della Resistenza. A Reggio venne a parlare Giorgio Almirante, che era stato uno dei dirigenti della Repubblica di Salò e che già aveva parlato l’anno prima nella nostra città, senza che si verificassero incidenti. Stavolta si scatenò la piazza. Sassi, urla, spinte, cariche delle polizia (venne colpito anche l’onorevole Otello Montanari, costretto a rivolgersi alle cure mediche). Almirante dovette parlare a tratti e poi cedere.
Nel mese di maggio e di giugno si susseguirono in Italia manifestazioni, scioperi, scontri anche violenti tra manifestanti e polizia. Il 28 e 30 giugno tutta Genova antifascista si mobilita per protestare contro la decisione di tenere il congresso del Msi nella città ligure. Il primo di luglio la città è letteralmente stretta d’assedio dalla polizia. Il congresso del Msi viene trasferito a Nervi. Non cambiava granchè. Ma la Genova antifascista gridò vittoria. La manifestazioni però non si placarono e il 5 luglio a Licata la polizia spara e uccide un manifestante ferendone altri 24. Il giorno dopo a Roma un corteo di antifascisti diretto al sacrario di Porta Sa Paolo viene attaccato dalla polizia e tra i feriti e i contusi vi sono anche alcuni parlamentari comunisti, tra quali Giorgio Amendola.
Il 4 luglio erano cominciati gli scontri anche a Reggio. I manifestanti, i giovani con le magliette a strisce, avevano assediato la sede del Msi di via Roma e ne erano nati numerosi scontri con le forze dell’ordine, che poi erano proseguiti in un cantiere di fianco al nuovo Isolato San Rocco, ove i manifestanti avevano aggredito gli agenti con sassi. I feriti, 28 da parte della polizia e cinque da parte dei dimostranti, erano stati ricoverati all’ospedale di Reggio. Alcuni agenti versavano in condizioni critiche. Non si placherà l’odio verso la polizia dopo i tragici avvenimenti del 7 luglio, tanto che uno di loro, Paolo Eboli, già partigiano e antifascista, padre dell’attuale consigliere comunale Marco, verrà aggredito in pieno centro-storico all’altezza della Banca agricola e commerciale (attuale Credem), portato in un portone e bastonato alla testa. A causa di queste ferite perderà la vista. La manifestazione del 7 luglio era stata vietata. Ma gli organizzatori (la Cgil reggiana) decisero di forzare il divieto. Puntavano all’incidente?
La polizia atterrita e mal preparata, o scientemente determinata a uccidere (al processo di Milano si sentenzierà che non vi fu premeditazione anche se un agente venne fotografato mentre prendeva di mira i bersagli umani) sparò. Nessuno l’aveva messo in conto? Nessuno pensava forse si potesse arrivare a tanto? Ma andiamo con ordine. L’unico spazio consentito (la sala Verdi, seicento posti) era troppo piccolo per contenere i manifestanti: un gruppo di circa trecento operai delle Officine Meccaniche Reggiane decide quindi di raccogliersi davanti al monumento ai Caduti, cantando canzoni di protesta. Alle 16.45 del pomeriggio una violenta carica di un reparto di 350 celerini al comando del vice-questore Giulio Cafari Panico investe la manifestazione. Cominciarono i caroselli degli automezzi della polizia che tentano di disperdere la folla anche utilizzando gli idranti. Anche i carabinieri partecipano alla carica. Incalzati dalle camionette, dalle bombe a gas, dai getti d’acqua e dai fumogeni, i manifestanti cercano rifugio ancora in uno stabile vicino all’isolato San Rocco, dove c’era un cantiere, e raccolgono assi di legno, sassi e altri oggetti contundenti.
Altri manifestanti buttano le seggiole dalle distese dei bar della piazza. Respinti dalla sassaiola dei manifestanti, i celerini impugnano le armi da fuoco e cominciano a sparare. Uno dei manifestanti, Giuliano Rovacchi, racconta: “Teng-teng, si sentiva questo rumore, teng-teng. Erano pallottole”, dice Rovacchi, “e noi ci ritirammo sotto l’isolato San Rocco. Vidi un poliziotto scendere dall’autobotte, inginocchiarsi e sparare, verso i giardini, ad altezza d’uomo”. In quel punto verrà trovato il corpo di Afro Tondelli, operaio di 35 anni. Si trovava isolato al centro di piazza della Libertà. Un agente estrae la pistola, s’inginocchia, prende la mira in accurata posizione di tiro e spara a colpo sicuro su un bersaglio fermo. Tondelli era stato partigiano della 76esima Sap (nome di battaglia Bobi), quinto di otto fratelli, in una famiglia contadina di Gavasseto. Davanti alla chiesa di San Francesco è Lauro Farioli, 22 anni, orfano di padre, sposato e padre di un bimbo. Lo chiamavano Modugno, grazie alla vaga somiglianza con il cantantautore del momento. Era uscito di casa con pantaloni corti, una camicetta rossa, le ciabatte ai piedi: ai primi spari si muove incredulo verso i poliziotti come per fermarli. Gli agenti sono a cento metri da lui: lo colpiscono in pieno petto.
Intanto l’operaio Marino Serri, 41 anni, partigiano della 76esima brigata, si affaccia urlando di rabbia oltre l’angolo della strada. Cade immediatamente, colpito da una raffica di mitra. Nato in una famiglia contadina e montanara poverissima di Casina, con sei fratelli, non aveva frequentato nemmeno le elementari: lavorava sin da bambino pascolando le pecore nelle campagne. Militare a 20 anni, era stato in Jugoslavia. Abitava a Rondinara di Scandiano, con la moglie e i figli. In piazza Cavour c’è Ovidio Franchi, un ragazzo, operaio di 19 anni. Viene colpito da un proiettile all’addome. Cerca di tenersi su, aggrappandosi a una serranda: “Un altro”, racconta un testimone, “ferito lievemente, lo voleva aiutare, poi è arrivato uno in divisa e ha sparato a tutti e due”. Franchi è la vittima più giovane (classe 1941, nativo della frazione di Gavassa): figlio di un operaio delle Officine Meccaniche Reggiane, dopo la scuola di avviamento industriale era entrato come apprendista in una piccola officina della zona. Nel frattempo frequentava il biennio serale per conseguire l’attestato di disegnatore meccanico, che gli era stato appena recapitato. Morirà poco dopo a causa delle ferite riportate. Emilio Reverberi, 39 anni, operaio, era stato licenziato nel 1951 dalle Officine Meccaniche Reggiane, dove era entrato all’età di 14 anni. Era stato garibaldino nella 144esima Brigata dislocata nella zona della Val d’Enza (commissario politico nel distaccamento Amendola). Nativo di Cavriago, abitava a Reggio nelle case operaie oltre Crostolo con la moglie e i due figli. Viene ucciso sotto i portici dell’Isolato San Rocco, in piazza Cavour. In realtà non era ancora morto: falciato da una raffica di mitra, spirerà in sala operatoria.
Polizia e carabinieri sparano con mitra e moschetti per quasi tre quarti d’ora, contro manifestanti armati solo di sassi. I morti sono cinque, i feriti centinaia. Drammatica anche la testimonianza del chirurgo Riccardo Motta: “In sala operatoria c’eravamo io, il professor Pampari e il collega Parisoli. Ricordo nitidamente quelle terribili ore, ne passammo dodici di fila in sala operatoria, arrivava gente in condizioni disperate. Sembrava una situazione di guerra: non c’era tempo per parlare, mentre cercavamo di fare il possibile avvertivamo, pesantissimi, l’apprensione e il dolore dei parenti”. I nomi dei morti verranno cantati nella canzone di Fausto Amodeo. Ai funerali partecipò Palmiro Togliatti con a fianco Nilde Iotti. Quella del luglio del 1960 non era un’epopea di ricordare con le sfilate del 25 aprile, ma un’esperienza direttamente vissuta anche per una generazione di ragazzi che non avevano conosciuto la lotta partigiana. Per altri sarà solo il racconto di una nuova terribile odissea. L’emozione fu immensa. Il sangue di Reggio Emilia era un nuovo richiamo e una nuova giustificazione a un impegno militante. Prendeva anche coloro che alla politica non avevano mai dato importanza e rimanevano per minuti sulle foto delle pozze di sangue pubblicate da “l’Unità” e su quelle meno trucide de “Il Resto del Carlino”, mentre la radio esaltava l’impresa di Nencini al Tour de France e Umberto Bindi cantava “Il nostro concerto”, una canzone che diveniva così quasi una colonna sonora di quei tragici avvenimenti.
Vi furono responsabilità dei manifestanti e soprattutto del sindacato e del partito che li ispirò? In una situazione analoga, nel 1915, Prampolini volle individuare le responsabilità dei manifestanti per la “sassata” alla polizia e non condannò a senso unico la spietata reazione delle forze dell’ordine che spararono uccidendo due giovani dinnanzi al teatro Ariosto, dove parlava l’interventista Cesare Battisti. Nel 1960 la condanna dei comunisti fu a senso unico. Tra i fatti del 1915 e quelli del 1960 c’erano però stati il fascismo e la lotta di resistenza. E il clima era divenuto più avvelenato anche a seguito dei numerosi morti provocati dalle forze dell’ordine durante la fase di Scelba. Vi furono responsabilità certo giustamente riconosciute da parte delle forze dell’ordine e soprattutto del governo che quell’acceso clima di revival della lotta antifascista aveva saputo far resuscitare. In fondo la decisione di sparare e di uccidere non poteva essere giustificata e ricondotta solo alla semplice paura. I due giornali reggiani (La “Gazzetta di Reggio” e il Resto del Carlino”) furono in trincea nel denunciare le violenze e le responsabilità dei dimostranti, del Pci e della Cgil.
Aveva scritto la “Gazzetta” il 6 luglio con un titolo eloquente: “Indignazione di tutta la città per la violenta dimostrazione comunista”, riferendosi agli incidenti del 4 luglio: “Ventinove feriti fra le forze dell’ordine e due tra i dimostranti. Vibranti proteste dei giovani liberali e dei partigiani cristiani. Nessun comunicato emesso dalla segreteria della Dc”. La “Gazzetta” aveva ricordato che il primo incidente si era verificato dopo il comizio di Cesare Campioli (Pci), Paolo Crocioni (Partito radicale) e Franco Boiardi (Psi). Un gruppo di giovani era risalito in via Roma dinnanzi alla sede del Msi, la polizia aveva tentato di frapporsi all’attacco e i giovani missini dall’interno avevano cercato di difendersi. Ne era nato un conflitto a base di sassi e poi una semplice scazzottatura. Boiardi, Campioli e Crocioni si erano poi recati dal vice questore per chiedere l’autorizzazione a un corteo che era stata negata. Da qui gli scontri con le auto della polizia, con sassi e corpi contundenti e i numerosi agenti feriti. Il Partito liberale, il giorno dopo, aveva duramente condannato questi episodi di violenza additando la responsabilità al Pci. Anche il Comitato provinciale dei partigiani cristiani dichiarava di non avere aderito al Comitato federativo della resistenza che aveva promosso la manifestazione. Ma anche dopo la morte dei cinque dimostranti, l’8 luglio, la “Gazzetta di Reggio” non cambiò d’un rigo la sua impostazione. E scrisse: “Cinque morti e diciassette feriti durante i gravi disordini di ieri.
A seguito dello sciopero proclamato dalla Cgil, una folla di alcune migliaia di persone si è radunata nel centro cittadino nonostante il divieto delle autorità. La polizia ha cercato di disperdere i dimostranti con lancio di candelotti lacrimogeni e successivamente sparando in aria. Poi la situazione è precipitata. Strette dalla folla che continuava a lanciare sassi e corpi contundenti le forze dell’ordine hanno sparato a più riprese”. La “Gazzetta” pubblicava anche un comunicato della Dc che sottolineava la responsabilità dei comunisti e della Cgil e che, dopo la strage, ugualmente affermava: “I tumulti di oggi sono avvenuti nel corso di uno sciopero che la Cgil aveva indetto senza intesa con le altre organizzazioni sindacali, anzi falsamente affermando che lo sciopero era stato concordato con la Cisl e la Uil”. La Dc reggiana vedeva solo due responsabili: il Pci e la Camera del lavoro. Non le forze dell’ordine che pure avevano sparato e ucciso.
Siamo così nel pieno del bipolarismo assoluto, quello che tendeva a falsificare la verità manipolandola. Se Pci e sinistre, da un lato, vedevano solo le responsabilità delle forze dell’ordine, Dc, Pli e giornali locali vedevano solo quelle del Pci e della Cgil. Non si riusciva a interpretare un episodio così drammatico con l’esclusivo amore per la verità. Per quale motivo non si poteva ammettere che vi erano stati ingiustificati e gravissimi atti di violenza (scatenata con sassi e altri corpi contundenti che avevano ferito e anche gravemente diversi agenti) da parte dei manifestanti e nel contempo ammettere che le forze dell’ordine avevano sparato per uccidere e la loro responsabilità, e quelle di chi li aveva diretti e istruiti, era gravissima?
Dal canto suo “il Resto del Carlino” aveva assunto più o meno analoga posizione. Nella prima pagina dell’edizione dell’8 luglio aveva titolato: “Cinque morti e decine di feriti a Reggio Emilia”, e poi “gli agenti di polizia hanno fatto ricorso alle armi per difendersi da gruppi di dimostranti muniti di pietre, sassi e corpi contundenti. Barricate con materiale divelto da una casa in costruzione”. Anche da parte de “il Resto del Carlino” nessun accenno a qualche responsabilità da parte delle forze dell’ordine.
In quello stesso giorno a Palermo e Catania si verificarono gravi incidenti che provocarono altri quattro morti. Il 9 luglio imponenti manifestazioni a Reggio Emilia (decine di migliaia di manifestanti), Catania e Palermo rilanciano la protesta. Tambroni arriva a collegare le manifestazioni a un complotto internazionale, ma il suo governo è ormai nell’angolo. Il 16 luglio la Confindustria firma con i sindacati l’accordo sulla parità salariale tra uomini e donne, il 18 viene pubblicato un documento sottoscritto da 61 intellettuali cattolici che intima ai dirigenti democristiani di non fare alleanze con i neofascisti. Il 19 luglio Tambroni si reca dal presidente Gronchi per dimettersi, il 22 l’incarico viene conferito ad Amintore Fanfani, che forma un governo appoggiato da repubblicani, liberali e socialdemocratici, con l’astensione del Psi, oltre che dei monarchici. Nasce così il governo dalle convergenze parallele. E Nenni fu alla fine colui che diede sbocco democratico alla crisi del 1960. Lo scrive egli stesso nei suoi Diari: “Togliatti me lo ha detto ieri, con una punta di rammarico: tu fai politica, noi ancora agitazione e propaganda”.
A Reggio rimase l’aspetto tragico della vicenda. L’epoca della guerra fredda, e a volte calda, segnò anche le direttrici della storia. Se da parte anticomunista si poteva delineare un filo di continuità tra i delitti del dopoguerra, il caso Magnani, la strage di Colombaia, le tragiche ammissioni sulle criminose gesta di Stalin del 1956, fino a quel che monsignor Wilson Pignagnoli chiama “il tentativo di colpo di stato comunista del luglio del 1960″ (difficile davvero poterlo interpretare come tale) da parte comunista si segnalava la mitologia della resistenza, il suo filo diretto con la resistenza tradita e i partigiani ingiustamente processati per delitti non commessi, l’epica lotta delle Reggiane, le discriminazioni anticomuniste e la sospensione di diversi sindaci da parte delle prefetture, appunto i morti in piazza del luglio del 1960. Così a Reggio, ancor più che altrove, ognuno restava prigioniero del suo mondo separato.
E anche quando il clima nazionale cambierà la situazione politica reggiana resterà ingessata, prigioniera di tanti “opposti estremismi”. I giovani del Sessantotto parleranno ancora della “resistenza tradita” e quelli che formeranno le bierre troveranno nei morti del 1960 e nei ragazzi delle “magliette a strisce” giustificazione della loro gesta. Quel che appare ancor oggi inconcepibile è che quegli avvenimenti tragici si siano verificati quando ormai la guerra fredda era al capolinea e quando il dialogo per l’apertura a sinistra era ormai maturo. La responsabilità politica di Gronchi (non istituzionale) e di parte della Dc in questo inutile, ma drammatico, ritorno al passato fu evidente. Le responsabilità dei singoli che spararono e di chi diede l’ordine di sparare furono giudicate inconsistenti dal tribunale di Milano nel 1964 proprio mentre anche i presunti responsabili della morte di Arnaldo Vischi (i loro nomi erano stati forniti da Robinson, il vecchio capo partigiano Alfredo Casoli, che nel 1961 aveva ucciso il suo vice, Muso, Rino Soragni) venivano assolti. Una mano lava l’altra? Il sangue di Reggio spesso non conosce responsabili.











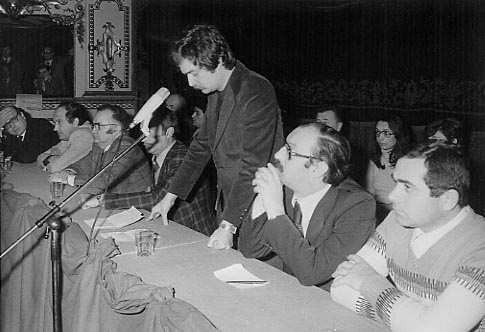

































































Leave your response!