Il discorso di Del Bue: “Perché ho premiato gli ultra”
Siamo qui a premiare tre ultra. Dietro questo termine si è sempre celato un significato negativo, come quasi in ogni eccesso, persino nei valori più esaltati, come l’amore e la bontà. L’eccesso che deturpa ogni virtù. Troppo amore e troppa bontà, possono a volte generare conseguenze negative. Nello sport, che è sfida col corpo che si unisce e condensa con la mente, non è così. Certo molti ultra hanno fatto una brutta fine: la sfida di Icaro finì male e così Filippide che s’accasciò privo di vita dopo la prima maratona della storia. Ma appunto non si trattava di gare sportive. La prima era un’originale dimostrazione scientifica peraltro molto utile per il prosieguo della ricerca sulla tecnica del volo, la seconda il tentativo di portare il messaggio agli ateniesi della storica sconfitta persiana. Icaro non si era allenato al salto nel vuoto e l’araldo Filippide non aveva mai corso per 42 chilometri. Gli sportivi si dedicano alla cura del loro corpo e si servono di controlli costanti, di cure mediche, di periodici allenamenti. Conoscono il confine e quando decidono di superarlo, e appunto si trasformano in ultra, sanno che la prova è plausibile, che la barriera è valicabile. Come abbattere quella dei 10 secondi netti nei 100 metri, che pareva un limite insuperabile. Alcuni (ero a Seul quel giorno delle Olimpiadi quando Ben Johnson illuse tutti, e per la verità da quel giorno sono cresciuti alquanto) si servono per questo di sostanze dopanti. E allora il discorso diventa diverso, perché la sfida è truccata. Lo sport si trasforma in logoramento inevitabile del corpo e in alterazione della mente, e le prestazioni in inganno popolare. Questo non è dovuto alla mitizzazione della vittoria (la vittoria e il record, il superamento dell’ostacolo, e De Coubertin sapeva in fondo che mentiva anche a se stesso, sono parte inseparabile dell’attività sportiva). Questo è dovuto, come le partite truccate nel calcio, alla mancanza di lealtà che generalmente dipende dalla scarsa considerazione che ognuno ha di se stesso. Il trucco è l’antisport per eccellenza. E’ l’obiettivo raggiunto per finta. E’ il successo solo mediatico e non atletico. E questo non è il nostro caso. Il nostro caso è esattamente l’opposto. E dunque questa serata che dedichiamo all’ultra la dedichiamo innanzitutto all’ultra pulito, autentico, generoso, che concepisce la sfida o la gara con regole condivise. La dedichiamo non a due sportivi da prima pagina e a tifosi che amano la copertina e le monetine da tirare in campo, che s’impegnano a offendere i propri giocatori intimando loro di togliersi le magliette. La dedichiamo a due reggiani e a un gruppo di tifosi che sono andati oltre da soli, senza grande pubblicità, senza televisioni, premiazioni, ovazioni. Senza generalmente podi e medaglie. A due atleti reggiani che sono andati oltre per sfidare innanzitutto loro stessi nello sport che prediligono, per ritornare al vecchio culto dell’uomo che nella classicità osava addirittura sfidare Dio. Cioè all’uomo che tentava di avere più poteri e perdeva sempre la sfida col più potente Zeus o Giove che fosse. Anche il termine greco della risurrezione è colto dall’“anastasis” che rivela il movimento del “salto in alto”, un balzo dalle tenebre della morte alla luce della vita. Si realizza l’evento nel modo che un’energia elevante investe l’atleta sospingendolo dal basso verso l’alto. Vedo che adesso anche Renzi usa l’immagine del salto in alto alla Fosbury per celebrare se stesso, non come dio, ma come atleta che innova, capovolge, modernizza. E che qualche analogia esista tra l’uso del corpo oltre misura e il ricorso a insegnamenti etico-religiosi appare bene anche nel famoso film Forrest Gumpe, quando il protagonista handicappato si mette a correre e non si ferma più e si forma dietro di lui un gruppo che si trasforma in comunità e che attende chissà perché un messaggio etico e viene invece deluso e frustrato dalla spiegazione della atleta che dopo centinaia di chilometri si ferma solo perché è un po’ “stanchino”. In Antonio Tallarita e in Fabrizio Bottazzi io vedo quel che Buzzati vedeva nella sfida Coppi-Bartali nel Giro del 1949, così romanzata e poetizzata. No, Bartali-Paride e Coppi-Achille, non c’entrano con Tallarita e Bottazzi. Ma lo spirito della sfida degli eroi classici questo sì che c’entra, eccome. C’entra perché l’uno e l’altro non sono prodotti del nostro tempo, dei nostri valori dominanti, della nostra ansia di apparire. Sono il contrario dell’effetto mediatico. La loro più grande soddisfazione non è quella della notizia della vittoria, ma quella del raggiungimento dell’obiettivo. Nella società dei mass media vedere Antonio Tallarita, ingegnere di 52 anni della Lombardini motori, correre da solo al circuito Cimurri di giorno e di notte, al sole e alla pioggia, alla nebbia e al gelo per entrare nel Guinnes dei primati (mille chilometri in dieci giorni tutti di corsa) rappresenta davvero una sorta di ritorno al passato più remoto. Avrebbe dovuto avere intorno a sé il pubblico della finale di Champions Leage. Invece c’erano solo sua moglie, il suo medico Roberto Citarella, più un nugolo di matti che intenerivano e che sembravano una vera propria Armata Brancaleone, come quella di Forrest Gump, raccapezzata da un paesino del Veneto o della Lombardia. Sembrava la sfida di un gruppo di amici del bar sotto casa. Era una sorta di record mondiale. Quando l’impresa si concluse abbiamo voluto accogliere Antonio con la banda e la bandiera del primo tricolore. Mi sembrava il minimo e lui si commosse, non se l’aspettava nemmeno. E aveva corso per mille chilometri, diconsi mille. Qualche mese prima aveva vinto la gara del centocinquantesimo dell’unità d’Italia: la Torino-Roma. Di oltre 700 chilometri, corsa più velocemente dei soldati di Cesare che sul Rubicone persero il cavallo. Il secondo era arrivato il giorno dopo com’era successo a Girardengo, che dopo una Milano-Sanremo del 1919 era tornato a Milano in treno e si stava già lavando quando l’ultimo corridore non era ancora arrivato nella cittadina ligure. E quando Fabrizio Bottazzi, dopo un incidente gravissimo, che gli troncò una carriera da ciclista professionista, decise di non mollare, di rinforcare la bici, di disputare non solo diverse Parigi-Rubaix e Liegi-Baston-Liegi, ma ultra gare, dimostrò che neppure la menomazione fisica poteva vincerlo. E andò oltre a superare i 500 chilometri tutti d’un fiato a Cuneo, e i 1000 e più chilometri alla Parigi-Brest e i 1.460 alla Londra-Edimburgo-Londra. Non meritava forse almeno il pubblico del Giro d’Italia? Tra i tanti valori dello sport, ho prima citato quello della lealtà. Ne emerge qui un altro. Quello più intimo e gelosamente custodito dell’emozione. Di quell’emozione pura che si raggiunge quando si sfila per le stradine e le pinete e i monti e ci si immerge nell’ambiente e si sente l’aria che ti accarezza il volto e poi il dolore che ti affligge, ma tu lo puoi controllare, perché sai vincere la fatica. L’emozione che un dopato non può conoscere. Perché sa che non è lui a vincere la sua fatica, non è lui a tagliare il traguardo della vittoria. E’ un farmaco, è un medico. E un farmaco e un medico ti possono aiutare ad andare oltre, anche molto oltre. Anche pericolosamente oltre. Ma non sei mai tu che ci vai. Antonio e Fabrizio, io vi ringrazio, ma so che quel che avete fatto e che farete non lo avete fatto e non lo farete per essere ringraziati da me e da nessun altro. Io vorrei potervi rubare, da podista e ciclista artigianal-fantozziano, quell’emozione. Che è ciò che vi invidio di più. L’emozione più forte, quella di chi è andato oltre, in rapporto che c’è (altro se c’è, caro Voltaire) tra il corpo e l’anima. E non tanto per quel vecchio detto latino “mens sana in corpore sano” (Leopardi e Gramsci insegnano che non è proprio così). Ma per quel forte influsso che una benefica prestazione del corpo determina nella mente, nello spirito o nell’anima per poter tornare al filosofo francese. Se io faccio sport sto bene, se io divento un ultra sportivo sto benissimo? No, non è detto. Anzi, Tallarita e Bottazzi vanno esaltati, ma non imitati. Si correrebbero seri rischi di tenuta psicofisica. Però io vorrei tornare a calarmi nell’emozione di Antonio quando è arrivato a Roma partendo da Torino di corsa. Si sarà sentito un garibaldino durante la breccia di Porta pia, Alarico o Tallarico, re dei Goti, che entrò a Roma partendo anche da più a nord, si sarà sentito come gli americani che entrarono nella capitale nel giugno del 1944 mangiando chewingum? E magari anche più bello di Gregory Peck che fece innamorare Audrey Hempurn in Vacanze romane nel 1953? E mentre dormiva per un’ora, Fabrizio, nella foresta inglese, a qualche centinaia di chilometri dal traguardo, quando gli dissero che era stato superato da un tedesco, cosa avrà provato? Dei tedeschi, voglio dire? Si sarà sentito un partigiano della Brigata Garibaldi, un rosso vicino al bunker di Berlino, un attore del Giorno più lungo? Sapete come si allena? Chiude il suo negozio alle sette di sera, inforca la bici e si sorbisce tutto il giro del Lago di Garda (oltre 350 chilometri) e rientra appena in tempo per riaprire la bottega la mattina dopo. Senza neanche un’ora di sonno. Pazzo? E io dovrei forse essere incuriosito dalle persone normali, che quando ne conosci una le conosci tutte? Fabrizio vende piatti in via Franzoni. Non bici da corsa come Francesco Moser. Piatti come quelli che una volta per far ridere qualcuno si tirava in faccia con le torte dentro. E se lo vedi lo scambi anche per un commerciante. E infine gli ultra, quelli per i quali si sono fatte le leggi eccezionali, stabiliti i biglietti nominativi, prodotti e installati i tornelli, erette barriere, istituiti gli steward e le videosorveglianze. Gli ultra di casa nostra. D’accordo, non saranno tutti così, ma questi signori, cari amici e lo dico anche alle autorità di pubblica sicurezza, sono ultra da premiare. Perché lo sono anche per generosità, altruismo, dedizione alla causa del prossimo. Già partecipiamo da anni alla serata dell’orgoglio reggiano intestata a quel grande sportivo che fu Chiarino Cimurri, e ogni anno il ricavato viene devoluto in beneficienza. Quest’anno i nostri hanno raggiunto il vertice e hanno venduto maglie granata con scritte in dialetto reggiano e modenese per i terremotati della provincia a noi vicina, superando qualsiasi forma di ottuso campanilismo in nome della fratellanza universale. “Mularegh mia, mular menga”, non mollare, che ben si addice nello sport e nella vita. Grazie Antonio, grazie Fabrizio, grazie ragazzi. Noi non ci molleremo.











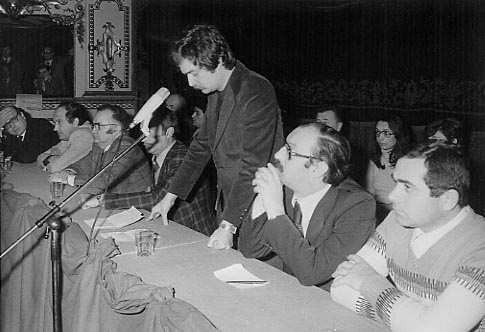

































































Leave your response!