Il marxismo tra dogma e revisione
Marx ha lasciato un segno forte su tutto il Novecento, nella politica, nella società, nella cultura. La sua lettura ha suscitato diverse interpretazioni sempre oscillanti tra dogma e revisione. A volte anche i più dogmatici sono poi stati considerati revisionisti, si veda il clamoroso caso di Kautski, che dopo aver litigato col traditore Bernstein, fu definito “rinnegato” da Lenin. Come diceva quel famoso detto: “C’è sempre un puro più puro che ti epura”. E capitò così, come nel cristianesimo, che quando un messaggio etico diventa religione, in tanti si trovino costretti (spesso malgrado il messaggio originario) a far la parte dei miscredenti. Già l’ultimo Engels poteva essere considerato un reprobo, quando nella famosa introduzione al libro “Le guerre civili in Francia”, volle sottolineare che con il suffragio universale il proletariato si poteva aprire un’altra forma di presa del potere che non fosse quella della rivoluzione violenta. Non ci voleva un genio per capirlo. Se il proletariato è la maggioranza della popolazione in ogni nazione basta che con le regole democratiche questa maggioranza si faccia valere col voto e il gioco è fatto. Anche se poi si sarebbe dovuto fare i conti con un’inevitabile reazione. Ma un conto è la violenza per difendere un diritto democratico, un altro conto è la violenza per affermare la ragione di una minoranza. A questo semplice schema si ispirarono i riformisti anche in Italia (Turati, Treves, Prampolini), i quali faranno della conquista, e poi del rispetto delle regole democratiche, la base per un progetto di trasformazione socialista della società. Quando il marxismo arrivò in Italia, grazie al professor Antonio Labriola, uno che sapeva tutto di Marx e che pretendeva che i socialisti gli dessero sempre retta, gli italiani erano più che altro radicali, repubblicani, umanitari e anche anarchici, generalmente d’impronta risorgimentale, attratti dal mito di Mazzini e Garibaldi, anche se si chiamavano socialisti. Aveva per questo ragione Labriola a diffidare del socialismo dei socialisti, ma se Turati e la Kuliscioff avessero dato retta a lui il partito non sarebbe nato mai. Per il filosofo napoletano, infatti, i tempi non erano mai maturi. E dal 1892 si sarebbe magari scivolati direttamente al 1992, sempre alla ricerca del momento della maturazione. Possiamo affermare che tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento i filosofi marxisti si divisero in due. Da una parte chi riteneva Marx intangibile e dall’altro chi lo riteneva quanto meno interpretabile, se non rivedibile. Tra questi ultimi poi c’erano revisionismi di destra e di sinistra. Il primo ortodosso fu Karl Kautsky, editore dell’ultimo libro de “Il Capitale” amico di Engels, che combattè le tesi di Eduard Bernstein, sul crollo o meno del capitalismo. Marx lo aveva profetizzato, e Kaustky ne era convinto, Bernstein invece no. Per Kaustky si poteva anche lottare per un programma minino (riforme), ma si doveva avere un programma massimo (rivoluzione), per Bernstein il proletariato, visto che il capitalismo non sarebbe certo crollato, avrebbe dovuto limitarsi a progredire con le riforme in seno al vecchio sistema che sarebbe andato via via modificandosi. Per quest’ultimo “il fine è nulla, il movimento è tutto”. Poi Kauszky, che marxista ortodosso era, ma che non diventò mai leninista, si schierò contro il bolscevismo perché quella sovietica era una rivoluzione in un paese arretrato e dunque non compatibile con le previsioni marxiste, destinata, come fu, a generare solo un nuovo dispotismo. Tra i revisionisti di sinistra possiamo citare Bakunin, che in realtà tanto marxista non fu mai. Non aderì alla prima Internazionale a Londra nel 1864, ma poco dopo vi entrò su pressione dello stesso Marx. Contestava l’autore de “Il Capitale” sul ruolo centrale della classe operaia. Per Bakunin erano i contadini la molla della rivoluzione che poi avrebbe dovuto generare una società senza classi, libera da ogni vincolo statuale. Bakunin venne in Italia, dove gli operai erano pochi e i contadini la maggioranza, e cominciò la sua predicazione incitando alla rivolta. Nuclei di giovani lo seguirono con entusiasmo e uno di loro, Andrea Costa, di Imola, fu tra i pochi che partirono proprio dalla Romagna (chi a piedi, chi a cavallo) con stracci, armi rudimentali e sogni di rivolta alla conquista del comune di Bologna. Andò male. La sua armata Brancaleone, composta di decine di infatuati, fu bloccata dalla polizia che arrestò tutti prima di arrivare a San Lazzaro. C’era anche un ricco signore tra i seguaci di Bakunin , certo Carlo Cafiero, che si spogliò di tutti i suoi averi per finanziare le imprese di questi generosi, temerari e folli utopisti e mise a disposizione anche una lussuosa villa al suo capo Bakunin sul lago di Garda. Neanche fosse Feltrinelli. Cafiero fu promotore di un altro tentativo rivoluzionario in Campania che finì male, coi rivoltosi che assaltavano comuni, davano alle fiamme gli archivi e le carte con attestate le proprietà private, proclamavano la terra bene pubblico e se ne andavano, ma quasi tutti in carcere o in esilio. Stanco della clandestinità Costa diventerà socialista e sarà il primo deputato, nel 1882, poi sarà vice presidente della Camera. Dalla rivolta alle istituzioni. Non avrà molto tempo da dedicare alla famiglia e la sua Kuliscioff divenne compagna di Turati e la figlia Adreina si accompagnò al nuovo binomio. Tra i revisionisti di sinistra c’è George Sorel, che poi finirà a destra, oscillando tra Lenin e Mussolini. Sorel era un esteta della rivoluzione, influenzato dal vitalismo bergsoniano. E concepì lo sciopero generale come strumento per la presa del potere da parte del proletariato. Attenzione, perché i riformisti su questo diventavano marxisti ortodossi e i rivoluzionari invece revisionisti. Sì, perché i riformisti sostenevano che Marx avesse previsto la rivoluzione solo a un certo livello di crescita del capitalismo (dunque non allora) e i rivoluzionari invece asserivano che la rivoluzione la volevano fare subito, ritenendo evidentemente che Marx avesse sbagliato a proporre questi impedimenti. Se il capitalismo (dicevano i riformisti) entrava in crisi da solo che bisogno c’era della rivoluzione violenta? Bastava educare e organizzare il proletariato in attesa di quel momento. I revisionisti di sinistra erano anticipazionisti, volevano fare presto, anzi subito, avevano fretta. Più che rivoluzionari erano eroi da fumetto. Canzonavano gli altri che rinviavano sempre al domani, perché avevano voglia di rivoluzione come uno ha voglia di mare. Le teorie soreliane furono talmente presenti nel dibattito teorico italiano che i sindacalisti rivoluzionari che le avevano sostenute (Leone, Arturo Labriola) conquisteranno la maggioranza all’interno del Psi per alcuni anni all’inizio del Novecento. Ma visto che gli scioperi generali (anche contro il parere dei riformisti) si facevano, il primo in Italia nel 1904, e la rivoluzione non scoppiava mai, anche i sindacalisti rivoluzionari cambiarono idea. Tanto che poi Arturo Labriola, da non confonderlo col filosofo Antonio, diventerà lui stesso riformista e aderirà al Psu di Turati, dopo essere stato nel 1920 ministro del Lavoro al tempo dell’occupazione delle fabbriche e prima di esaltare Mussolini dopo la guerra d’Etiopia. Chi non cambia mai idea, deve essersi ripetuto, è proprio scemo… In Italia l’unico riformista che apertamente si schierò con il revisionismo di Bernstein fu Ivanoe Bonomi, che assieme a Bissolati e altri riformisti di destra, furono espulsi dal Psi nel 1912 e fondarono il Partito socialista riformista italiano, mentre Turati, Prampolini, Treves, erano, nel breve, per le riforme, senza però osteggiare il disegno più generale della socializzazione dei mezzi di produzione. Un fine lontano però, e come tutte le prospettive che si inscrivono in un remoto futuro, piuttosto indecifrabile. Carlo Rosselli inventò più tardi il suo socialismo liberale, contestato anche dai riformisti per il suo eccesso di revisione. Ma siamo già alla fine degli anni venti. Diciamo che la posizione teorica riformista fu ampiamente maggioritaria fino all’esplosione della prima guerra mondiale. In Italia fino all’impresa libica del 1911. Quando prevalsero il colonialismo, il nazionalismo e la stessa democrazia assunse altri caratteri, la certezza che si potesse progredire serenamente e pacificamente verso il socialismo vacillò. E dopo la rivoluzione bolscevica del 1917 (nel bel mezzo della carneficina europea) il leninismo iniziò a suscitare la speranza di un radicale cambiamento sociale anche altrove. Il leninismo appariva come l’attuazione pratica del marxismo, la fuoriuscita dalle parole e la sua trasformazione in azione concreta. Il braccio del libro del profeta tedesco. Nascevano i contrasti sulla natura non operaia della rivoluzione (fatta da soldati, contadini e dirigenti politici), sulla dottrina della dittatura del proletariato trasformata in dittatura del partito, sul tema della violenza, necessaria per arrivare al nuovo sistema. Su tutto questo si consumarono le divisioni tra comunisti, assolutamente asserviti al dogma leninista, e socialisti, che nella loro frazione massimalista erano ondeggianti e attratti dal comunismo (in Francia i massimalisti aderirono al Partito comunista subito, in Italia in parte vi aderirono solo nel 1924) e nella frazione riformista rifiutavano invece il comunismo, difendendo il carattere democratico e libero del socialismo. A quest’ultima posizione diede il suo contributo teorico quel che viene chiamato “austromarxismo” di Viktor Adler e Otto Bauer che coniugavano Marx con le particolari situazioni di ogni paese e ne ricavavano una concezione democratica e riformistica, salvaguardo il Marx dal volto umano. L’umanismo marxista del quale parla anche l’italiano Rodolfo Mondolfo tanto influenzò Giuseppe Saragat e la sua formazione politica. Le vicende del dopoguerra, le rivoluzioni europee mancate (in Germania con la guerra civile, in Italia col tentativo del biennio rosso), mentre in Ungheria la rivoluzione riuscì e si installò nel 1919 la Repubblica sovietica di Bela Kun, poi soffocata dal colpo di stato di Horty, la progressiva trasformazione delle democrazie occidentali (tranne la Francia e l’Inghilterra) in regimi autoritari, la guerra di Spagna che mise gli uni contro gli altri i repubblicani appoggiati dai comunisti, dai socialisti, dai democratici di mezzo mondo, ma dalla sola Unione sovietica, e dall’altro i fascisti e i nazisti, appoggiati da Hitler e Mussolini, con l’ipocrita neutralismo di Francia e Inghilterra, fecero piazza pulita di molte certezze. Nacque l’idea, che risultò prevalenta nelle sinistra italiana e non solo, che il capitalismo e il nazifascismo fossero due facce della stessa medaglia, anzi che la reazione dei regimi nazifascisti fosse la risposta del capitalismo, come lo era stata la prima guerra mondiale, al tentativo di conquista del potere da parte del movimento operaio. Il capitalismo aveva alzato il livello di scontro? O era stata la rivoluzione bolscevica e leninista ad alzare il livello di scontro? Il marxismo e il leninismo apparvero ancora una ricetta valida. Tra i filosofi più famosi di quest’epoca vi è certamente l’ungherese Georgy Lukacs, che al tempo della Repubblica socialista ungherese ebbe anche incarichi politici. Era nato letterato e critico d’arte, si trasformò in uno dei filosofi marxisti più influenti, vera e propria liason tra il marxismo del primo novecento e l’esistenzialismo di Sartre e della scuola di Francoforte. Lukacs volle insistere soprattutto sui temi della dialettica e dell’alienazione dell’uomo nella moderna fabbrica, nonché sull’irrazionalismo, come base ideale dei fascismi europei. Non farà in tempo (morì nel 1929) a vivere la fase dei processi staliniani, del patto Molotov-Ribbentrop, dello stalinismo degli anni quaranta. Ma il suo marxismo (anche su temi della difesa dell’arte) non era certamente favorevole a giustificare metodi repressivi, autoritari, brutali. La scuola di Francoforte, così definita, perché i vari Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkeimer ma anche Erich Fromm, avevano fondato un centro di ricerca filosofica a sfondo sociale proprio nella città tedesca, apre nuovi orizzonti al marxismo. Non lo considera certo un dogma e nemmeno però accetta le sue revisioni precedenti, in chiave riformistica. Costoro saranno costretti a vivere il dramma del nazismo e si trasferiranno prima a Parigi e poi in America, tornando, ma solo alcuni, nell’immediato dopoguerra a Francoforte. La loro comune radice è l’adesione a una dialettica negativa nei confronti della società, che pare come nemica dell’uomo. Esistono certo le contraddizioni di cui parla Hegel, solo che Hegel salva sempre tutto immaginando un processo positivo. Le contraddizioni della stessa ragione con la realtà risultano invece permanenti, senza un radicale capovolgimento sociale. Horkeimer distingue tra ragione soggettiva e ragione oggettiva, essendo quella soggettiva tipica di una società industriale che opprime l’uomo fingendosi libera. Quella oggettiva invece è sostanzialmente la sua. D’altronde quante volte si è detto: “Credo oggettivamente”. Come si può credere oggettivamente e non soggettivamente non me lo ha spiegato neppure la mia professoressa di Liceo. Il loro punto di riferimento critico diventa la società americana anche se la loro adesione al marxismo (lo affermò lo stesso Horkheimer che alla fine se ne distaccherà piuttosto nettamente) faceva i conti con l’affermazione dei regimi totalitari in larga parte dell’Europa e col sostanziale fallimento della rivoluzione leninista sfociata nella dittatura staliniana. La loro critica alla società borghese si avvale non del solo Marx, ma di Freud e della sua teoria degli istinti (che a loro giudizio sono repressi per far funzionare la società che così della repressione di avvale), della teoria del conoscenza di Kant e della dialettica hegeliana. In “Eros e civiltà” Marcuse e in “Avere o essere” Fromm rileggono Freud e lo coniugano con l’identità di una società divisa in classi. Uno, insomma, che lavora alla catena di montaggio avrà istinti repressi ben maggiori di uno che vive di rendita e la sera è fuori a godersi la vita. O no? Come può soddisfare la sua libido un operaio alienato? Magari con qualche fotografia di Playboy incollata alle pareti. E solo con la catena (di montaggio). Così un Freud a sfondo classista e marxista viene utilizzato per l’analisi della società industriale moderna. Fromm in particolare elabora una sua intelligente critica alla società dei consumi che concepisce l’uomo per quel che ha, cioè come un semplice consumatore. Per parafrasare Cartesio: “Ho, dunque sono”. E il cogito? Marcuse, soprattutto, sarà il mito dei giovani del sessantotto, che pur non avendolo mai letto, avevano imparato a memoria un paio di frasi captate qua e là. La prima, e più ripetuta, era quella di stampo immobiliare: “Una casa va distrutta e non riammodernata se se ne vuole costruire una nuova”. E questo giustificava gli istinti rivoluzionari dei capelloni anni sessanta con chitarra ed eskimo, assai propensi a teorizzare la rivoluzione in assemblea. E poi: “L’uomo non può essere a una dimensione” (dal famoso libro di Marcuse). Cioè non si può studiare latino e greco a memoria, perché vogliamo studiare meno e parlare di più, occupare la scuola e sancire la fine delle supplenti coi baffi. A parte le semplificazioni resta però un contributo importante quello recato dai filosofi tedeschi della scuola di Francoforte. E tra loro quello di Horkheimer, che alla fine della sua esistenza confesserà che Marx si era illuso che i proletari avrebbero migliorato le loro condizioni di vita solo eliminando il capitalismo. Invece le hanno migliorate col capitalismo. Bastava che avesse letto Bernstein che aveva detto le stesse cose cento anni prima. E non lo avesse invece gettato nel cestino. E poi, come capita a tutti coloro che sono alla ricerca di una verità oggettiva, anche Horkeimer devierà alla ricerca di un Dio la cui esistenza non si può certo dimostrare con la ragione, ma che rappresenta pur sempre una speranza, l’anelito di un mondo migliore. Che era sempre meglio del socialismo reale dell’Urss. Oddio, non era una conclusione originale.











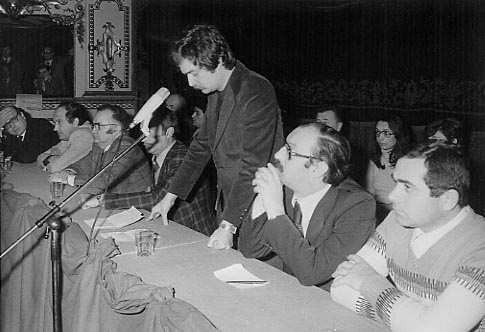

































































Leave your response!